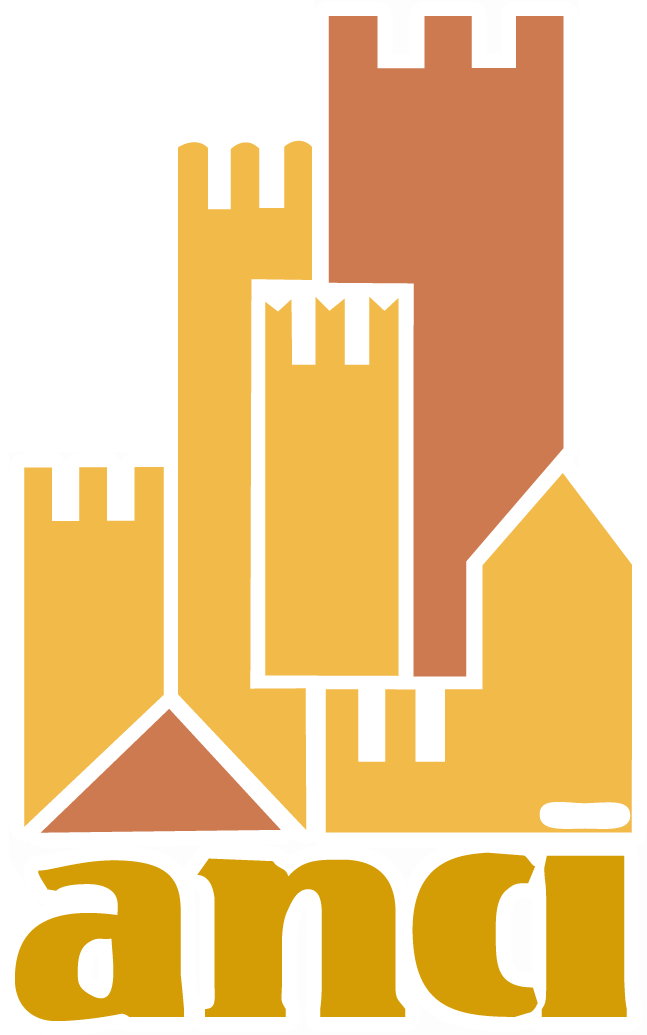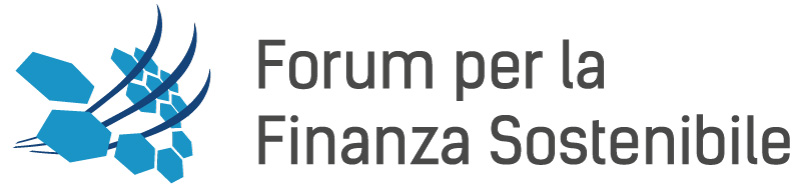Ci stiamo mangiando il suolo. Il rapporto Ispra 2025 registra il dato peggiore degli ultimi 12 anni. Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia: «Continuiamo a distruggere una risorsa indispensabile alla vita»
La popolazione decresce ma il consumo del suolo aumenta. È un pericolo per il nostro futuro, servono politiche serie e un censimento delle strutture abbandonate che possono essere riconvertite
«In Italia il consumo di suolo non accenna a frenare e rappresenta un pericolo concreto per il nostro futuro». Lo dichiara Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, a commento del puntuale e preciso Rapporto Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici di Ispra e Snpa presentato oggi. Dallo studio si apprende che nel 2024 sono stati consumati 83,7 chilometri quadrati di suolo, in crescita del 15,6% rispetto all’anno precedente. Il consumo netto (il dato che tiene conto del ripristino di aree naturali) è stato di 78,5 chilometri quadrati: è il peggior saldo degli ultimi dodici anni.
«Consumare suolo – prosegue Nappini – non significa soltanto deturpare il paesaggio, ma distruggere una risorsa indispensabile alla vita. Il suolo è una risorsa non rinnovabile, scarsa e non esiste tecnologia che possa sostituire i suoi servizi ecosistemici: fornisce materie prime, biomassa e il cibo necessario alla sopravvivenza dell’uomo e di tutte le altre specie viventi; è elemento fondamentale del ciclo vitale sulla Terra; rappresenta una riserva di biodiversità, un serbatoio di carbonio ed è regolatore del ciclo dell’acqua e degli elementi biochimici. Senza suolo non c’è agricoltura e senza agricoltura non c’è cibo».
Senza suolo non può esserci vita, eppure le attività umane continuano a eroderlo. A farne le spese sono le aree più accessibili e anche le più fertili. Preoccupa in particolar modo il consumo di suolo agricolo. Ogni anno nuove cause di consumo si sommano a quelle tradizionali. Nel 2024 il rapporto ne individua altre tre: le aree destinate alla logistica, i data center e i pannelli fotovoltaici a terra. Questi ultimi impattano in modo sensibile: in dodici mesi hanno coperto 1.702 nuovi ettari, di cui l’80% su superfici precedentemente utilizzate ai fini agricoli. Il dato fotografa un trend in forte crescita: gli impianti di questo tipo sono aumentati di oltre venti volte nel giro di quattro anni appena. Non va dimenticato che il consumo di suolo, sommato all’abbandono delle aree interne, oltre a provocare danni all’agricoltura e al tanto sbandierato Made in Italy, ha impatti economici e ambientali significativi: ad esempio aumenta il rischio idrogeologico (alluvioni, frane) i cui danni annuali complessivi raggiungono, secondo stime recenti, i 3,3 miliardi di euro (dal 2010 ad oggi la spesa è triplicata), più di un sesto della manovra in discussione al parlamento.
«In un’Italia dove la popolazione diminuisce, l’unica cosa che continua a crescere è il consumo di suolo – conclude Nappini –. Cresce perché ogni nuovo metro quadrato costruito porta soldi nelle casse dello Stato o degli enti locali, attraverso gli oneri di urbanizzazione. Ma il suolo non è una voce da inserire in bilancio: è un bene pubblico da proteggere. Serve un censimento di tutte le costruzioni e infrastrutture abbandonate che possono essere riconvertite: oggi le coperture artificiali occupano il 7,17% del territorio italiano, quasi il doppio della media europea. Non è affatto poco, se pensiamo che solo il 23,2% dell’intero territorio nazionale è pianeggiante e che oltre un terzo è montano. Ci sono regioni, la Lombardia, il Veneto e la Campania, dove più di un decimo del suolo è già consumato. Il nostro futuro è nel suolo, non sprechiamolo».
Urgono soluzioni immediate e servono consapevolezza e senso di responsabilità da parte di tutti. ll Regolamento europeo sul ripristino della natura impone l’azzeramento della perdita netta di aree verdi urbane entro il 2030 e la Strategia del suolo per il 2030 adottata dalla Commissione Europea nel 2021 stabiliva l’obiettivo per tutti gli stati membri di non consumare suolo entro il 2050 – ma questi target sono irraggiungibili, allo stato attuale.
In questo contesto gravissimo, c’è una sola buona notizia: ieri il parlamento europeo ha approvato la direttiva sul monitoraggio del suolo, che vincola gli stati membri ad agire per migliorare la resilienza del suolo. Per Slow Food Italia si tratta di un passo significativo, che stimola ad agire al più presto e che dimostra l’urgenza di decisioni coraggiose.
Ufficio stampa Slow Food Italia
Elisa Virgillito 3452598615, Valter Musso 335 742 2962, Elena Coccia 348 012 0860 – stampa@slowfood.it
Legambiente: “I dati più negativi dal 2012, anno dell’inizio del monitoraggio. Il consumo di suolo aumenta in un Paese in declino demografico. Approvare una legge per una vera rigenerazione urbana e modificare l’articolo 5 del decreto agricoltura”
Buone notizie da Bruxelles: ieri approvata la Direttiva europea sul suolo. Ma i suoli agricoli sono sempre più minacciati: meno tutele contro erosione, contaminazione e perdita di humus
Quelli presentati oggi sono i più negativi, da quando vengono pubblicati annualmente i dati sul consumo di suolo: se il consumo di suolo è l’impronta vista dall’alto della crisi climatica, allora la situazione restituita per il nostro Paese appare decisamente critica. Dal 2012, anno in cui ISPRA ha avviato il proprio sistema di monitoraggio, non si era mai registrata una perdita così estesa di suoli agricoli, a seguito della crescita di urbanizzazioni e infrastrutture. Un dato ancora più sconcertante se si considera che questa corsa alla cementificazione avviene in un Paese in declino demografico. Preoccupa anche lo spostamento del fenomeno verso sud: Puglia, Sicilia e Sardegna raggiungono o superano oggi i livelli di consumo di suolo di regioni tradizionalmente più urbanizzate come Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio.
Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente dichiara: “Sempre più cemento sui campi, sempre meno abitanti in città: pesano responsabilità di amministratori locali, ma anche un quadro obsoleto di norme, nazionali e regionali, inadeguate a fornire strumenti per il governo sostenibile delle trasformazioni urbane e territoriali. È necessario invertire la rotta, per puntellare con disposizioni di legge il principio ‘zero consumo netto di suolo’, orientando il settore delle costruzioni al rinnovo degli spazi già costruiti per puntare all’aggiornamento delle città secondo criteri di reale rigenerazione urbana e di adattamento alla crisi climatica. È altrettanto urgente modificare l’articolo 5 del DL agricoltura che ha vietato il fotovoltaico a terra, che si limita a usare il suolo, che invece viene consumato pesantemente da nuove aree residenziali o produttive, poli logistici e data center, che è ancora possibile paradossalmente realizzare per legge sui terreni agricoli del nostro Paese”.
In un contesto generale piuttosto cupo, arriva da Bruxelles una notizia positiva: ieri sera il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la direttiva sul suolo, la Soil Monitoring Law. Si tratta della prima normativa europea dedicata alla tutela dei suoli, anche se il testo finale risulta molto meno ambizioso rispetto alla proposta iniziale. Nata con l’obiettivo di proteggere la salute e l’ecologia dei terreni europei, la direttiva si limita ora a definire un quadro comune di monitoraggio del suolo, con particolare attenzione ai diversi fattori di degrado, a partire dalla contaminazione.
“La direttiva – dichiara Damiano Di Simine, responsabile suolo di Legambiente – non risponde certo alle aspettative della petizione europea da noi promossa a suo tempo con l’iniziativa dei cittadini europei People4soil, ma segna comunque un precedente di valore storico: per la prima volta, la tutela del suolo entra nel diritto dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri. Grazie alla norma approvata ieri possiamo almeno iniziare a sviluppare una piattaforma comune di dati e conoscenze accurate sullo stato di salute dei suoli, e definire criteri comuni per il loro risanamento, un aspetto non secondario se si considerano le migliaia di siti contaminati presenti nel nostro Paese e in tutti gli Stati dell’Unione. Confidiamo in tempi migliori per poter quanto prima passare dalla conoscenza alla tutela del suolo”.
Secondo Legambiente, l’approvazione della direttiva, pur insufficiente, rappresenta un segnale in controtendenza rispetto all’indebolimento delle politiche ambientali che incidono sulla salute del suolo. È il caso del pacchetto delle norme di semplificazione, che indeboliscono la normativa sull’uso dei pesticidi in agricoltura aprendo all’uso di deroghe anche per sostanze non autorizzate, e attenuando il principio di precauzione sull’uso di sostanze chimiche in campo aperto. Ma anche dell’ammorbidimento delle norme di condizionalità presupposte all’accesso degli aiuti della PAC, la Politica Agricola Comune di cui beneficia gran parte delle aziende agricole europee: il testo votato nelle scorse settimane dall’Eurocamera per la ‘semplificazione’ della PAC, infatti, oltre a concedere maggiori possibilità di dissodare i prati stabili, elimina le norme volte a limitare le lavorazioni dei suoli suscettibili di causare erosione, ed inoltre consente di convertire i terreni condotti a prato o pascolo nei siti della rete Natura2000.
“I suoli – ricorda Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente – devono essere tutelati non solo dal consumo di cemento, ma anche da pratiche agricole che ne compromettono la salute. Il suolo è la cassaforte della vita sulle terre emerse: un terreno sano trattiene la CO₂, legandola all’humus, elemento chiave della fertilità. In molte aree agricole italiane, però, l’humus sta diminuendo a ritmi preoccupanti. In un contesto aggravato dagli eventi estremi legati alla crisi climatica, è insensato continuare con lavorazioni aggressive che favoriscono erosione e dissesto. Le superfici a prato e pascolo vanno invece considerate un vero patrimonio nazionale: sono i nostri suoli migliori, fondamentali per un allevamento sostenibile e ricchi di biodiversità.”
Ufficio stampa di Legambiente:
Ilenia De Simone 371 5962334-
Luisa Calderaro 349 6546593 capo ufficio stampa – Rita Murgese 375 8573864